19 maggio 2019 - V Domenica di Pasqua - Anno C
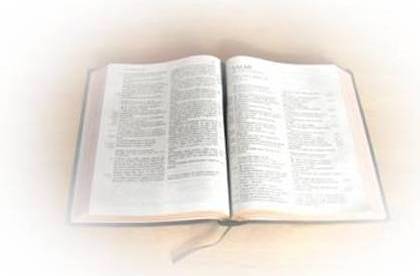 At 14, 21-27; Sal 144; Ap 21, 1-5; Gv 13, 31-33. 34-35.
At 14, 21-27; Sal 144; Ap 21, 1-5; Gv 13, 31-33. 34-35. «Solo chi non vive per se stesso, vive responsabilmente, ossia vive»
D. Bonhoeffer
Un dovere di riconoscenza
Mia mamma è una persona molto generosa. Benché non abbia mai vissuto in condizioni economiche floride, le è sempre piaciuto rendersi presente con gesti di attenzione, con un regalo o una piccola sorpresa. Eppure, ogni volta che qualcuno cerca educatamente di ringraziarla, risponde sempre con la solita frase lapidaria pronunciata in napoletano e che suona più o meno così: «chi ringrazia, esce fuori obbligo!».
Per molti anni mi sono chiesto il senso di questa espressione, fino a quando mi sono accorto che era l’immagine di una cultura, nella quale anche lei è cresciuta. È l’invito a rimanere obbligati, a non pensare che le cose siano gratuite. In effetti, il regalo crea, almeno nel nostro modo ordinario di pensare, un dovere di riconoscenza. Riceviamo un dono, pensando già a come ricambiare. Siamo presi dalla smania di riportare le cose in equilibrio per non sentirci sminuiti, poveri o ingrati. Vogliamo ricompensare.
Reciprocità o gratuità?
E su questa idea, che non è per niente evangelica, abbiamo costruito norme di pseudo educazione civica. Abbiamo elevato la reciprocità a valore. E in questo modo abbiamo distrutto la gratuità, che è invece profondamente evangelica.
Capiamo bene che dietro questa visione della relazione c’è anche l’idea di un modo di amare. Si può amare cercando sempre l’equilibrio o si può amare accettando anche di perdere.
Il comandamento dell’amore che Gesù ci consegna in questi versetti del Vangelo di Giovanni ha il sapore della reciprocità o dello spreco?
«Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri». Gv 13,34
Il criterio è Gesù
Potremmo essere ingannati infatti dalla correlazione cosi…come. Se però guardiamo all’intera espressione (e all’insieme del Vangelo), ci rendiamo conto che la reciprocità scompare. Gesù dice di amarci gli uni gli altri, come egli ci ha amati. Occorre quindi andare a vedere come egli stesso ci ha amati e imitare il suo stile. Non si tratta, dunque, di cercare la misura nella reciprocità: quello che hai fatto a me lo faccio a te, ma si tratta di fare all’altro quello che Gesù ha fatto, e fa, con me! Il criterio è quindi esterno alla relazione e va cercato nel modo stesso in cui Gesù ama ciascuno di noi.
Immagini dello spreco
Se guardiamo alcune immagini evangeliche, ci rendiamo conto che il modo di amare di Gesù è quello dello spreco:
- il seminatore uscì a seminare e gettò il seme in ogni tipo di terreno: il seminatore non si sofferma solo sul terreno buono, non getta il seme solo laddove spera di ottenerne un guadagno (Mt 13,3-9);
- gli operai dell’ultima ora riceveranno un denaro come quelli che avevano lavorato per una giornata intera, perché l’amore non fa i conti (Mt 20,1-16);
- la donna che a Betania spacca il suo vasetto di alabastro e unge il corpo di Gesù, senza preoccuparsi, a differenza di Giuda, di quello che può sembrare uno spreco, ha capito bene qual è il modo di amare di Gesù (Mc 14,3-9).
La partita doppia
Se la modalità di amare propria di Gesù è quella dello spreco, la nostra è al contrario quella della partita doppia: è come se continuamente volessimo far tornare i conti delle relazioni. Siamo disposti al più a rimanere in pareggio, ma certamente non a perdere. Ci rendiamo conto che stiamo amando veramente invece quando chiudiamo in rosso i conti dell’amore.
Un genitore sa bene che questa è la dinamica dell’amore. Diventiamo adulti infatti quando impariamo ad amare così. Il bambino, invece, è ripiegato sul suo bisogno e non vede altro. Questa modalità infantile di amare che vuole tutto per sé, che fa i capricci e vede solo il proprio interesse, perdura spesso nella vita di tanti falsi adulti.
La copertura dell’equilibrio
La reciprocità può renderci buoni cittadini, ma certamente non ci rende buoni cristiani. Gesù ci sta invitando a spezzare gli equilibri per non imitare Giuda, il buon cittadino che denuncia Gesù alle autorità, fa i conti per evitare gli sprechi, ma fondamentalmente rimane un ladro e un traditore. Molte volte coloro che si fanno paladini della reciprocità e della correttezza sono quelli che hanno qualcosa da nascondere e che impiegano tutta la vita a tenere le cose in equilibrio per evitare che emerga il loro disordine.
Leggersi dentro
- Il tuo modo di amare è quello della reciprocità o quello dello spreco?
- Come reagisci quando ricevi un dono gratuito?
P. Gaetano Piccolo S.I.
Compagnia di Gesù (Societas Iesu)
da: Congregazione del Clero / Omelie
12 maggio 2019 - IV Domenica di Pasqua Anno C
 I seduttori e i maestri: due voci ben diverse
I seduttori e i maestri: due voci ben diverseIn quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non i comandi, la voce. Quella che attraversa le distanze, inconfondibile; che racconta una relazione, rivela una intimità, fa emergere una presenza in te. La voce giunge all'orecchio del cuore prima delle cose che dice. È l'esperienza con cui il bambino piccolo, quando sente la voce della madre, la riconosce, si emoziona, tende le braccia e il cuore verso di lei, ed è già felice ben prima di arrivare a comprendere il significato delle parole. La voce è il canto amoroso dell'essere: «Una voce! L'amato mio! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline» (Ct 2,8). E prima ancora di giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della voce dell'amata: «La tua voce fammi sentire» (Ct 2,14)... Quando Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, la sua voce fa danzare il grembo: «Ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo» (Lc 1,44). Tra la voce del pastore buono e i suoi agnelli corre questa relazione fidente, amorevole, feconda. Infatti perché le pecore dovrebbero ascoltare la sua voce? Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori, quelli che promettono piaceri, e i maestri veri, quelli che danno ali e fecondità alla vita. Gesù risponde offrendo la più grande delle motivazioni: perché io do loro la vita eterna. Ascolterò la sua voce non per ossequio od obbedienza, non per seduzione o paura, ma perché come una madre, lui mi fa vivere. Io do loro la vita. Il pastore buono mette al centro della religione non quello che io faccio per lui, ma quello che lui fa per me. Al cuore del cristianesimo non è posto il mio comportamento o la mia etica, ma l'azione di Dio. La vita cristiana non si fonda sul dovere, ma sul dono: vita autentica, vita per sempre, vita di Dio riversata dentro di me, prima ancora che io faccia niente. Prima ancora che io dica sì, lui ha seminato germi vitali, semi di luce che possono guidare me, disorientato nella vita, al paese della vita. La mia fede cristiana è incremento, accrescimento, intensificazione d'umano e di cose che meritano di non morire. Gesù lo dice con una immagine di lotta, di combattiva tenerezza: Nessuno le strapperà dalla mia mano. Una parola assoluta: nessuno. Subito raddoppiata, come se avessimo dei dubbi: nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io sono vita indissolubile dalle mani di Dio. Legame che non si strappa, nodo che non si scioglie. L'eternità è un posto fra le mani di Dio. Siamo passeri che hanno il nido nelle sue mani. E nella sua voce, che scalda il freddo della solitudine.
(Letture: Atti 13,14.43-52; Salmo 99; Apocalisse 7,9.14-17; Giovanni 10,27-30)
(commento di Ermes Ronchi)
5 maggio 2019 - III Domenica di Pasqua Anno C
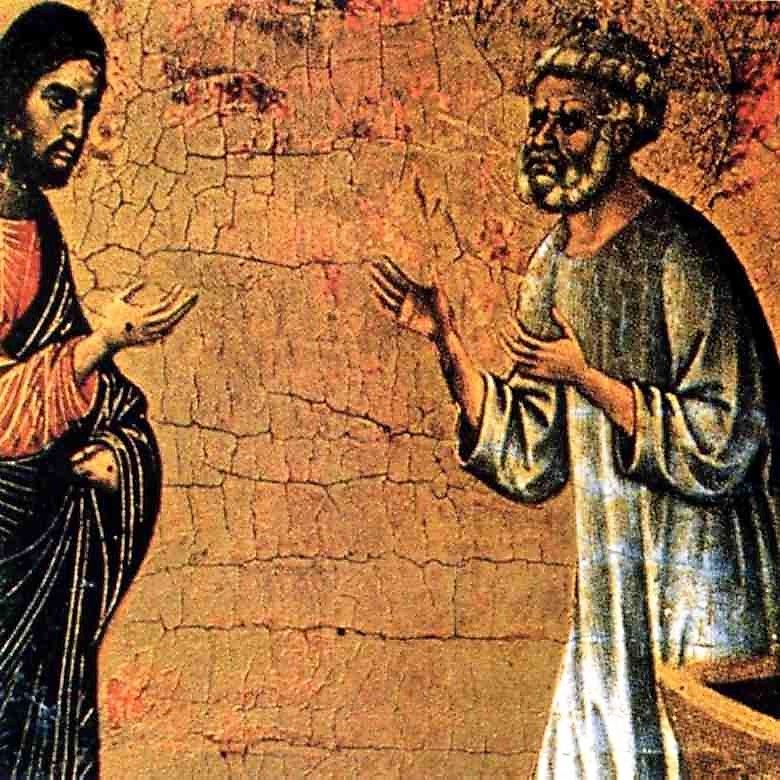 Alla fine saremo tutti giudicati sull'amore
Alla fine saremo tutti giudicati sull'amoreIn quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade (...). Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» (...)
In riva al lago, una delle domande più alte ed esigenti di tutta la Bibbia: «Pietro, tu mi ami?». È commovente l'umanità del Risorto: implora amore, amore umano. Può andarsene, se è rassicurato di essere amato. Non chiede: Simone, hai capito il mio annuncio? Hai chiaro il senso della croce? Dice: lascio tutto all'amore, e non a progetti di qualsiasi tipo. Ora devo andare, e vi lascio con una domanda: ho suscitato amore in voi? In realtà, le domande di Gesù sono tre, ogni volta diverse, come tre tappe attraverso le quali si avvicina passo passo a Pietro, alla sua misura, al suo fragile entusiasmo.
Prima domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gesù adopera il verbo dell'agápe, il verbo dell'amore grande, del massimo possibile, del confronto vincente su tutto e su tutti.
Pietro non risponde con precisione, evita sia il confronto con gli altri sia il verbo di Gesù: adotta il termine umile dell'amicizia, philéo. Non osa affermare che ama, tanto meno più degli altri, un velo d'ombra sulle sue parole: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene, ti sono amico!
Seconda domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Non importano più i confronti con gli altri, ognuno ha la sua misura. Ma c'è amore, amore vero per me? E Pietro risponde affidandosi ancora al nostro verbo sommesso, quello più rassicurante, più umano, più vicino, che conosciamo bene; si aggrappa all'amicizia e dice: Signore, io ti sono amico, lo sai!
Terza domanda: Gesù riduce ancora le sue esigenze e si avvicina al cuore di Pietro. Il Creatore si fa a immagine della creatura e prende lui a impiegare i nostri verbi: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene, mi sei amico?». L'affetto almeno, se l'amore è troppo; l'amicizia almeno, se l'amore ti mette paura. «Pietro, un po' di affetto posso averlo da te?».
Gesù dimostra il suo amore abbassando ogni volta le sue attese, dimenticando lo sfolgorio dell'agápe, ponendosi a livello della sua creatura: l'amore vero mette il tu prima dell'io, si mette ai piedi dell'amato. Pietro sente il pianto salirgli in gola: vede Dio mendicante d'amore, Dio delle briciole, cui basta così poco, con la sincerità del cuore.
Quando interroga Pietro, Gesù interroga me. E l'argomento è l'amore. Non è la perfezione che lui cerca in me, ma l'autenticità. Alla sera della vita saremo giudicati sull'amore (Giovanni della Croce). E quando questa si aprirà sul giorno senza tramonto, il Signore ancora una volta ci chiederà soltanto: mi vuoi bene? E se anche l'avrò tradito per mille volte, lui per mille volte mi chiederà: mi vuoi bene? E non dovrò fare altro che rispondere, per mille volte: sì, ti voglio bene. E piangeremo insieme di gioia.
Commento di Padre Ronchi
21 aprile 2019 - Domenica di Pasqua - Anno C
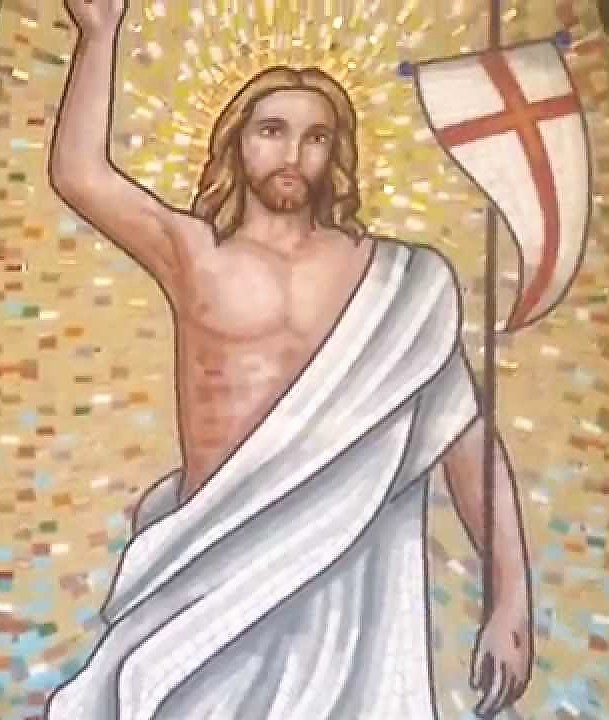 At 10, 34. 37-43; Sal. 117; Col 3, 1-4; Gv 20, 1-9
At 10, 34. 37-43; Sal. 117; Col 3, 1-4; Gv 20, 1-9
Cristo dormì perché stessimo svegli noi, Lui che era morto perché fossimo vivi noi.
Sant’Agostino Sermo 221, 4
Un nuovo inizio
C’è un inizio in ogni cosa. Anche quando tutto sembra finito, la vita rinasce. Il fiore, silenziosamente, sboccia. Nonostante le paure, l’incertezza e i dubbi sul futuro, la vita ricomincia e un nuovo inizio è sempre possibile. Anche se il desiderio di ricominciare deve affrontare ogni volta il combattimento con la tentazione di mollare, sappi che la morte è stata sconfitta e la vita può sempre ricominciare!
È questo il messaggio della Pasqua, e il testo del Vangelo di Giovanni descrive realisticamente la fatica di credere che la vita ricomincia e tutto si rinnova anche quando ci sembra impossibile.
Come il primo giorno
È di nuovo il primo giorno, come una nuova creazione. La morte sta lasciando spazio alla vita, ma è difficile crederci, è difficile immaginare che davvero le cose possano ricominciare di nuovo. Quel sentimento di sgomento, il senso della sconfitta, la delusione amara ci abitano.
Maria di Magdala si reca al sepolcro quando è ancora buio. Inizia il suo viaggio appena possibile, animata da un desiderio irrefrenabile o forse semplicemente per lo scrupolo di completare ciò che non era stato possibile portare a termine. Maria cerca un corpo da ungere, un dovere da espletare. Cerca un sepolcro su cui piangere, un luogo dove riversare il suo lamento.
Siamo fatti così: piuttosto che fare la fatica di ricominciare, preferiamo cercare sepolcri su cui piangere. Ci fermiamo lì. A volte ci passiamo una vita intera e non vediamo più le luci di un futuro possibile.
È ancora buio, forse perché è ancora buio proprio nel cuore di Maria, nel cuore di una persona che non riesce a vedere il sole che sorge. Nel cuore di Maria c’è il buio della confusione, l’oscurità della tristezza, il crepuscolo della delusione.
Il vuoto e l’assenza
Molte volte ci accorgiamo che un nuovo inizio è possibile solo quando passiamo attraverso un’assenza. Il vuoto ci rivela che non si può andare più avanti così. Dentro quel sepolcro Maria non trova più nulla, neppure un corpo da piangere. Maria trova uno spazio vuoto. Ed è lì che sperimenta la fatica dell’inizio e il rischio di fermarsi. Il vuoto può essere la voragine in cui precipitiamo oppure può spingerci a cercare. Maria poteva fermarsi lì e sprecare la sua vita nella voragine del lamento. Quello che lei cercava non c’è.
Maria si lascia invece interrogare da quella assenza. Si chiede dove sia il suo maestro, dov’è colui che il suo cuore cerca. Come la sposa del Cantico dei Cantici, Maria si getta nella notte della delusione per cercare colui che ama. Quando ami veramente non ti rassegni, ma ti metti a cercare. Anche se è notte.
Proprio come la sposa del Cantico, anche Maria chiede aiuto, si confronta, si lascia accompagnare. E così anche Pietro e l’altro discepolo, colui che Gesù amava, diventano immagine di coloro che sono chiamati a intraprendere un nuovo inizio, a partire da situazioni diverse. Quel vuoto non lascia indifferenti, ma paradossalmente è ciò che spinge a cercare, tutti devono mettersi in movimento a partire dal loro presente.
Una fede stanca
Pietro è l’immagine di una fede che cerca continuamente di capire. I conti non gli tornano. È l’immagine di una fede stanca, che non riesce a correre. È una fede indebolita dal tradimento. Una fede che ha ancora bisogno di essere guarita. Pietro arriva al sepolcro, osserva anch’egli quel vuoto. Vede i teli e il sudario lasciati in ordine, come se tutto fosse avvenuto con calma, ma di Pietro non si dice che crede. Pietro inizia un cammino che lo porterà sul lago di Galilea. E lì, la sua guarigione passerà attraverso quel triplice interrogativo sull’amore.
La fede di chi si sente amato
L’altro discepolo, quello che Gesù amava, non ha nome, forse per dare a ognuno di noi la possibilità di prendere il suo posto. Quel discepolo è l’immagine di chi ha fatto l’esperienza di sentirsi amato da Gesù. Ha ascoltato il suo cuore. È rimasto sotto la croce. Si è sentito chiamare e consegnare al cuore di una Madre. Questo discepolo è immagine di una fede piena di entusiasmo che sa correre, ma sa anche aspettare. Questo discepolo lascia infatti che Pietro entri per primo. È il discepolo che crede anche se non ha ancora compreso. Per lui, questo nuovo inizio significa ritrovare il desiderio di amare, lasciare che il cuore si riaccenda.
Un invito a ripartire
La Pasqua è il nuovo inizio che non comincia con una risposta, ma parte da un vuoto. La fede comincia con una ricerca, nasce quando ci troviamo davanti a una domanda: dov’è il mio Signore? Dov’è la mia vita? Dove cercherò per me un nuovo inizio?
I racconti della risurrezione ci invitano quindi a ripartire, qualunque sia la situazione in cui ci troviamo. Possiamo ritrovare la speranza, perché un nuovo inizio è sempre possibile.
Leggersi dentro
- Da dove può ripartire oggi la tua vita?
Sei fermo al sepolcro, sei immerso nel lamento o stai cercando un nuovo inizio?
P. Gaetano Piccolo S.I.
Compagnia di Gesù (Societas Iesu)
da: Congregazione del clero / omelie
14 aprile 2019 - Domenica delle Palme Anno C
 Fattosi carne il Verbo ora entra anche nella morte
Fattosi carne il Verbo ora entra anche nella morteInizia con la Domenica delle Palme la settimana suprema della storia e della fede. In quei giorni che diciamo «santi» è nato il cristianesimo, è nato dallo scandalo e dalla follia della croce. Lì si concentra e da lì emana tutto ciò che riguarda la fede dei cristiani. Per questo improvvisamente, dalle Palme a Pasqua, il tempo profondo, quello del respiro dell'anima, cambia ritmo: la liturgia rallenta, prende un altro passo, moltiplica i momenti nei quali accompagnare con calma, quasi ora per ora, gli ultimi giorni di vita di Gesù: dall'entrata in Gerusalemme, alla corsa di Maddalena al mattino di Pasqua, quando anche la pietra del sepolcro si veste di angeli e di luce. Sono i giorni supremi, i giorni del nostro destino. E mentre i credenti di ogni fede si rivolgono a Dio e lo chiamano nel tempo della loro sofferenza, i cristiani vanno a Dio nel tempo della sua sofferenza. «L'essenza del cristianesimo è la contemplazione del volto del Dio crocifisso» (Carlo Maria Martini). Contemplare come le donne al Calvario, occhi lucenti di amore e di lacrime; stare accanto alle infinite croci del mondo dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli, nella sua carne innumerevole, dolente e santa. Come sul Calvario «Dio non salva dalla sofferenza, ma nella sofferenza; non protegge dalla morte, ma nella morte. Non libera dalla croce ma nella croce» (Bonhoeffer). La lettura del Vangelo della Passione è di una bellezza che mi stordisce: un Dio che mi ha lavato i piedi e non gli è bastato, che ha dato il suo corpo da mangiare e non gli è bastato; lo vedo pendere nudo e disonorato, e devo distogliere lo sguardo. Poi giro ancora la testa, torno a guardare la croce, e vedo uno a braccia spalancate che mi grida: ti amo. Proprio a me? Sanguina e grida, o forse lo sussurra, per non essere invadente: ti amo. Perché Cristo è morto in croce? Non è stato Dio il mandante di quell'omicidio. Non è stato lui che ha permesso o preteso che fosse sacrificato l'innocente al posto dei colpevoli. Placare la giustizia col sangue? Non è da Dio. Quante volte ha gridato nei profeti: «Io non bevo il sangue degli agnelli, io non mangio la carne dei tori», «amore io voglio e non sacrificio». La giustizia di Dio non è dare a ciascuno il suo, ma dare a ciascuno se stesso, la sua vita. Ecco allora che Incarnazione e Passione si abbracciano, la stessa logica prosegue fino all'estremo. Gesù entra nella morte, come è entrato nella carne, perché nella morte entra ogni carne: per amore, per essere con noi e come noi. E la attraversa, raccogliendoci tutti dalle lontananze più perdute, e a Pasqua ci prende dentro il vortice del suo risorgere, ci trascina con sé in alto, nella potenza della risurrezione.
(Letture: Isaia 50,4-7; Salmo 21; Filippesi 2,6-11; Luca 22,14-23,56).
meditazione di Ronchi Ermes
7 Aprile 2019 - V DOMENICA DI QUARESIMA - anno C
![]()
 Is 43,16-21 - Sal 125 - Fil 3,8-14 - Gv 8,1-11
Is 43,16-21 - Sal 125 - Fil 3,8-14 - Gv 8,1-11
Se volessimo dare un denominatore comune alle letture di questa V domenica di Quaresima,
potremmo dire, in un parola sola, che questo è la ‘novità’.
La prima lettura, tratta dal profeta Isaia, ci descrive infatti il ‘nuovo esodo’ che il Signore ha
preparato per il suo popolo, esiliato in Babilonia. Come nel primo esodo, quello dall’Egitto, la salvezza
di Israele si è compiuta grazie ai segni di potenza con cui Dio è intervenuto nella storia del popolo (e il
profeta qui ricorda in particolare il passaggio del mare e la disfatta dell’esercito del Faraone, cf Is 43,16-
17, che richiama Es 15,15-31), così il Signore prepara una “cosa nuova” (Is 43,19), un nuovo intervento
di liberazione per il popolo oppresso: Israele attraverserà il deserto per ritornare alla terra promessa
e Dio lo accompagnerà aprendo per lui una strada e facendo sgorgare fonti d’acqua per dissetarlo (Is
43,20, che è eco di Es 17,1-7). Allora il popolo dei redenti, investito dalla novità di Dio per lui, rinnovato
dall’azione di Dio nella sua storia, canterà le lodi del Signore (Is 43,21, che può alludere a Es 15).
Anche il Salmo responsoriale è tutta una esplosione di gioia per l’opera che il Signore ha compiuto
in favore di Israele, l’opera di ristabilimento delle sue sorti, cioè, anche in questo caso, il ritorno dall’esilio
babilonese e il reinsediamento nella terra promessa. La parola che più ricorre nel Salmo è “gioia” (vv.
2-3.5-6) e i suoi sinonimi, quale risposta alle “grandi cose” (vv. 2-3) che il Signore ha fatto per il suo
popolo. La novità di Dio, il suo intervento di salvezza, è anche qui, come in Is 43, paragonato a un
erompere di torrenti nel deserto, il deserto del Negheb, nel sud di Israele (v. 4).
L’apostolo Paolo, nella seconda lettura, pur non usando alcun termine del campo semantico della
novità, usa delle immagini equivalenti: parla infatti di qualcosa che sta alle sue spalle, nel suo passato,
e che lui oggi considera come spazzatura, qualcosa che va rigettata nella misura che gli impedisce di
protendersi verso quanto gli sta di fronte, cioè verso la piena conoscenza di Cristo Gesù (Fil 3,7-8). Ciò
che Paolo considera incompatibile con la novità di Cristo è la sua precedente osservanza scrupolosa delle
norme della Legge mosaica e delle tradizioni farisaiche, nelle quali riponeva la sua fiducia in vista della
salvezza eterna. Grazie all’incontro con Cristo, però, l’Apostolo ha compreso che nulla di tutto questo
vale davvero, perché la salvezza non deriva dalla Legge, ma dalla fede in Cristo, “la giustizia che viene
da Dio, basata sulla fede” (Fil 3,9). È nella relazione viva con Gesù, è “la comunione alle sue sofferenze,
facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti” (Fil 3,10) che
come cristiano posso raggiungere la meta, il premio, della mia vita di fede: non l’osservanza di un codice
di norme morali, ma il rapporto vitale con Gesù Signore permette alla vita cristiana uno slancio di novità
continua. Questo non le consente mai di adagiarsi nei risultati già conseguiti, ma le dona le energie per
lo “sforzo di correre per conquistare” la meta (Fil 3,12): una meta che è sempre nell’oltre, è sempre
davanti, e lascia nell’uomo una sana inquietudine di perfezione mai raggiunta, finché non consegua il
Parola di Dio
85
“premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù” (Fil 3,14).
Anche il Vangelo, apparentemente, non parla in modo esplicito di novità: racconta un tranello
che scribi e farisei vogliono porre a Gesù, per avere di che accusarlo (Gv 8,3-6). E la trappola consiste
nel chiedere a Gesù cosa bisogna fare con una donna sorpresa in flagrante adulterio, peccato che la
Legge di Mosè punisce con la lapidazione. Essi sanno che Gesù è il maestro che non si limita a ripetere
la Legge, ma che la radicalizza e la supera, e per questo gli pongono la domanda, per vedere se arriverà
a contraddire la Legge di Mosè. Al principio Gesù sembra volersi sottrarre al trabocchetto, rifiutando
una risposta diretta: il suo scrivere per terra però può alludere a Ger 17,13: “Quanti si allontanano da
te saranno scritti nella polvere, perché hanno abbandonato il Signore, fonte di acqua viva”. Forse Gesù
vuole ricordare agli scribi e ai farisei questo passo di Geremia perché tutti si rifletta sui propri volontari
allontanamenti dal Signore.
Di fronte all’insistenza degli accusatori della donna, Gesù esprime il suo giudizio sulla situazione:
e non è un giudizio di condanna verso la donna, come non lo è verso nessuno. È un richiamo agli
accusatori dell’adultera a fare un esame di coscienza per vedere se qualcuno di loro sia così innocente di
peccato, da potersi permettere di giudicare il comportamento di questa donna colta in flagrante peccato.
Alla fine tutti se ne vanno, anche la donna è invitata da Gesù ad andare, ma qualcosa è avvenuto: “Va’ e
d’ora in poi non peccare più” (Gv 8,11). Gesù, offrendo il suo perdono, rende capace la donna di una
vita nuova, la abilita a vivere quella novità, che nasce dalla relazione profonda con il Signore, quell’andare
oltre, di cui ci ha parlato S. Paolo, frutto della comunione al mistero di passione e risurrezione di Gesù:
quella novità che ci fa vivere la tensione continua verso la Pasqua eterna, di cui la festa di Pasqua, che è
ormai vicina, è solo annuncio e pregustazione.
V DOMENICA DI QUARESIMA sussidio C.E.I.
31 Marzo 2019 - IV Domenica di Quaresima - Anno C
 Gs 5, 9. 10-12; Sal 33; 2 Cor 5, 17-21; Lc 15, 1-3.
11-32.
Gs 5, 9. 10-12; Sal 33; 2 Cor 5, 17-21; Lc 15, 1-3.
11-32.
«È il Verbo stesso che ti grida di tornare; il luogo della quiete imperturbabile è dove l’amore non conosce abbandoni», Agostino d’Ippona
La fragilità dell’amore
Le relazioni si spezzano, inevitabilmente. Ci perdiamo nei labirinti delle nostre attese, lasciando all’altro un filo da seguire nella speranza di essere raggiunti. Ci perdiamo nei nostri viaggi mentali, abbandoniamo la realtà con le sue pesantezze e non sappiamo più ritornare nel porto dal quale siamo partiti. Ci perdiamo nell’abitudine e non sappiamo più riconoscere la persona che abbiamo davanti.
C’è sempre qualcuno che si perde: una
moneta, una pecora, un figlio. Ognuno si perde a suo modo. Eppure, anche se non
ne siamo consapevoli, c’è sempre qualcuno che ci sta già cercando: una donna,
un pastore, un padre.
Una ricerca d’affetto
Il figlio minore della parabola ha deciso di perdersi, il figlio maggiore invece si è perso e non se n’è neppure reso conto.
Il figlio minore è l’immagine di tutti coloro che vogliono una relazione senza vincolo, sono coloro che sono stanchi del peso dell’amore. Il figlio minore è il bambino capriccioso che vuole tutto per sé, vede solo i suoi bisogni, non c’è spazio per la vita degli altri. Per il figlio minore, l’altro può anche morire. E infatti accadrà così: il padre divide la sua essenza (sostanza), si lacera, rinuncia a vivere per lasciare vivere il figlio. E rimane nell’attesa che quel bambino cresca e si renda conto di dov’è la vera vita. Intanto lo lascia andare, perché l’amore passa inevitabilmente attraverso la libertà dell’altro.
Quel figlio minore si incammina verso la sua ricerca d’affetto, inseguendo un ideale inesistente. Il padre sa che prima o poi incontrerà la realtà. Quello sarà il tempo della consapevolezza. Il figlio minore in questa sua ricerca di affetto senza vincolo finisce invece paradossalmente per ritrovarsi in situazioni invischiate, dove perde la sua dignità. Si lascia trattare come un animale, si incolla (si mise a servizio) a un padrone: succede proprio così, ci allontaniamo da un padre, in nome della libertà, e ci ritroviamo incastrati dentro situazioni degradanti.
A maggior ragione il figlio minore si
convince che l’unico modo per stare in una situazione è essere schiavi
dell’altro. E come tante altre persone, il figlio minore cerca ancora relazioni
in cui essere servo. Pensa addirittura di tornare nella casa del padre per fare
il servo anche lì. Solo una persona che ci ama veramente può aiutarci a uscire
da questa visione distorta della relazione.
Quando il cuore è altrove
Ci sono anche coloro però che pur
restando in una relazione, vi rimangano solo apparentemente, ma il loro cuore è
altrove. Come il figlio maggiore, vivono da bambini adattati, cercando di
rispondere in maniera efficace alle attese dell’altro. Il loro atteggiamento
esterno è il compiacimento, ma dentro covano una rabbia profonda e distruttiva,
che prima o poi non può non emergere.
Percorsi di riconciliazione
Il padre è immagine non solo di Dio, ma di tutti coloro che non si arrendono davanti alla fragilità dell’amore. Il padre costruisce per tutti cammini di riconciliazione. Non si tratta di fantasie o di buone intenzioni, ma di cammini che si esprimono attraverso segni concreti.
Il padre non ha mai smesso di aspettare il figlio, perché l’amore non cede, non dimentica, non archivia. Non è passato giorno che il padre non abbia sperato che il figlio tornasse, per questo lo vede da lontano, lo vede da quel giorno lontano in cui la relazione si è spezzata. Lo sguardo del padre ha continuato a guardare l’orizzonte verso il quale la figura del figlio si è dissolta.
Il padre lascia che il figlio minore condivida la consapevolezza di aver sbagliato, ma non gli permette di chiedere di essere servo. La riconciliazione passa attraverso gesti concreti: il vestito che ridona dignità, come quelle tuniche di pelli che Dio confeziona dopo il peccato di Adamo ed Eva, perché nonostante il peccato, l’uomo non perde mai la sua identità di figlio. Spesso il mondo ci spoglia della nostra dignità, ci umilia, Dio invece ci riveste anche quando abbiamo sbagliato.
Il padre consegna al figlio l’anello, simbolo della sua regalità e del suo potere di figlio. L’anello recava il sigillo per segnare le proprietà. Pur essendo stato tradito, il padre continua a dare fiducia, altrimenti la relazione non sarebbe né piena né autentica.
Al figlio vengono anche messi i calzari
ai piedi, segno dell’uomo libero. Solo lo schiavo cammina a piedi nudi, ma il
padre desidera che in quella relazione il figlio continui a sentirsi libero. Ma
il segno più grande è certamente il vitello ammazzato per fare festa. È Pasqua.
Il padre celebra la vita del figlio. Solo allora la relazione è vera, quando
siamo capaci di dire all’altro: io celebro la tua vita!
Una decisione da prendere
Ma il padre costruisce cammini di riconciliazione anche per il figlio maggiore. Il padre sa che anche quel figlio è lontano. Sa che dietro l’apparenza di una presenza c’è invece una profonda distanza. Il figlio maggiore è rappresentato sempre fuori dalla casa. È distante nelle relazioni al punto di doversi informare tramite un servo di quello che avviene nella sua stessa casa. È un uomo che non vive le relazioni, tanto che non pronuncia mai la parola fratello. Chissà da quanto tempo quel figlio maggiore se n’era già andato lontano dal cuore del padre.
E il padre esce anche per lui, ma il padre non banalizza il dolore di questo figlio, non lo richiama al senso del dovere, non minimizza il suo rancore. Il padre gli offre il suo cuore, si fa vedere fragile, lo rimanda a quella profonda comunione possibile: tutto quello che è mio è tuo.
Il figlio maggiore regredisce a una condizione adolescenziale e vive di confronti. È immagine di tutte quelle persone che non godono del loro presente, ma sono perennemente in competizione con gli altri. Sono persone profondamente arrabbiate. E quando sei arrabbiato non vedi più come stanno veramente le cose. La rabbia ci fa assolutizzare, facciamo di tutta l’erba un fascio. Quella parola mai, che il figlio maggiore pronuncia per lamentarsi di un presunto trattamento ingiusto, è indice di quel processo di distruzione totalizzante proprio della rabbia. Forse sarà effettivamente capitato che qualche volta non ci sia stato il vitello, ma il figlio maggiore rilegge tutta la sua storia di relazione con il padre come una storia di mancanza e ingiustizia.
Il padre lo invita a rientrare nella casa/relazione e a guardare come stanno veramente le cose. Solo così può riscoprire il cuore del padre e il volto autentico del fratello.
Non sappiamo però come sia terminata
questa storia. La parabola costruita da Gesù è aporetica, resta aperta. È un
invito per noi, nel nostro oggi, a deciderci. Ovunque ci troviamo nel percorso
della nostra vita, quella porta resta aperta. Il cuore del padre ci aspetta.
Possiamo decidere cosa farne. Ma siamo anche invitati, come il Padre, a non
chiudere mai le porte a chi si è allontanato dalla relazione con noi,
aspettando che prima o poi si decida a tornare.
Leggersi dentro
- Ci sono percorsi di riconciliazione che oggi sei chiamato a costruire?
-
Cosa fai quando ti senti a disagio in una relazione?
P. Gaetano Piccolo S.I.
Compagnia di Gesù (Societas Iesu)
da: Congregazione del Clero / Omelie
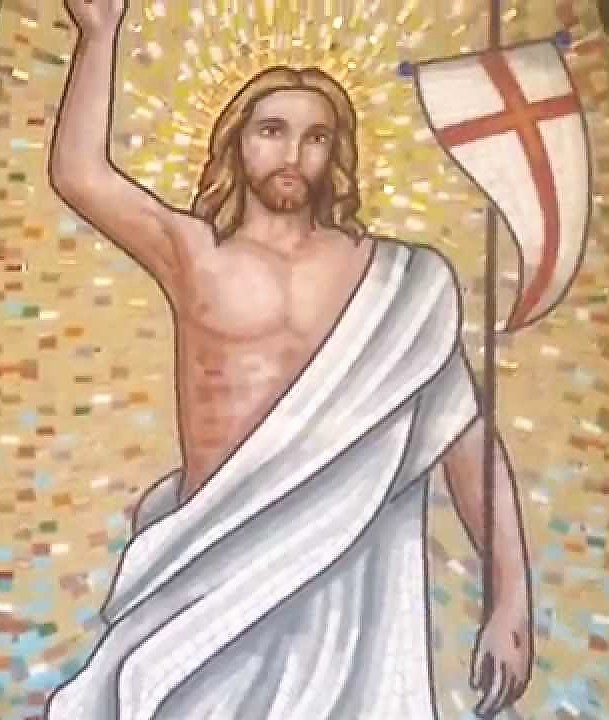
 Is 43,16-21
Is 43,16-21